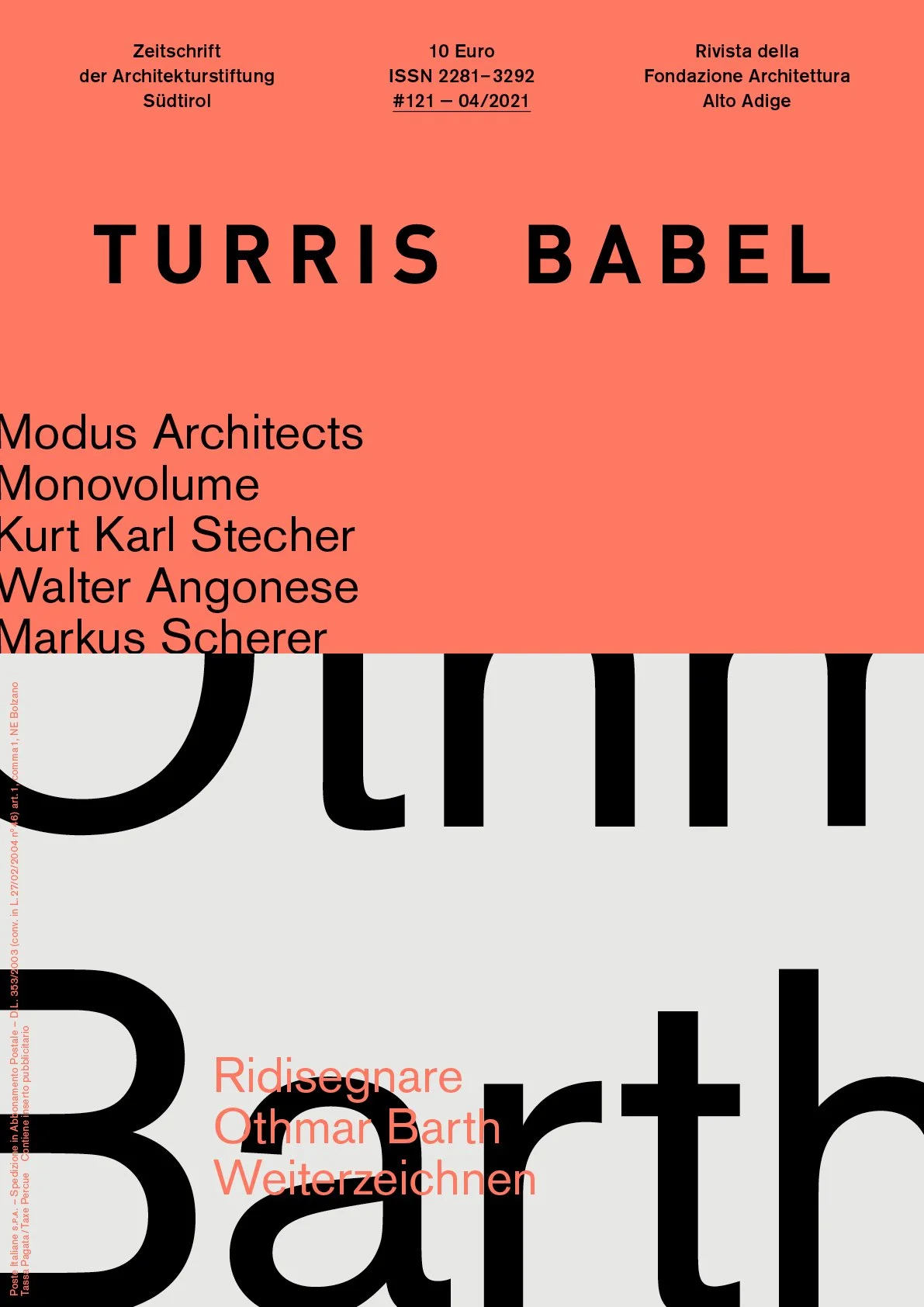Questa edizione di Turris Babel è direttamente legata e conseguente al precedente numero TB 120 «Riscoprire Othmar Barth», in cui abbiamo presentato sei opere particolarmente significative del noto architetto sudtirolese, provando a comprenderne le ragioni e a seguirne la genesi attraverso i disegni e i plastici, dalle prime ipotesi progettuali fino alle versioni definitive e realizzate. In questo secondo numero siamo andati a scoprire in che modo quelle stesse sei opere selezionate sono state rilette, riprogettate e attualizzate da cinque studi sudtirolesi. Si tratta di due numeri ideati come un unicum, ma che lasciano tra loro uno spazio di sospensione utile per valutare con una maggiore attenzione le differenze tra le opere originarie e i recenti interventi di trasformazione che le hanno interessate.
Nonostante ci siamo limitati a studiare solamente sei lavori, scelti in relazione alla loro successiva sorte, è emersa con forza la potenza delle architetture di Othmar Barth e la sua particolare capacità di dialogare con il contesto senza rinunciare ad introdurre segni di una modernità in quell’epoca ancora poco conosciuta sul territorio provinciale.
Pur appartenendo a uno specifico momento storico, soprattutto quello degli anni ’70 e ’80, il lavoro di Barth è caratterizzato da una sorta di atemporalità, diventata feconda fonte generatrice di un fermento architettonico contemporaneo ancora in atto. Uno spirito lucidamente descritto da Silvano Bassetti in uno dei primi articoli che tentano una lettura sistematica del fenomeno de «l’architettura in Sudtirolo», comparso nel numero 27 di Turrisbabel nel marzo del 1993: «Solo a partire dagli anni ’60 si vedono i segni e un positivo risveglio culturale dell’architettura sudtirolese. E proprio a Barth va attribuito il merito storico di avere riallacciato il filo di quel discorso avviato dai maestri sudtirolesi del ’900 e interrotto brutalmente dal fascismo. L’alto profilo culturale del «nuovo maestro» brissinese, peraltro confermato dal prestigio anche internazionale della sua figura, appare evidente fin dalle sue opere dei primi anni ’60. In esse mette a frutto la multiformità della sua formazione fondata sull’esperienza universitaria austriaca, sul tirocinio professionale bolzanino con Weyhenmayer e sulla formazione romana con Nervi. In questo intreccio di riferimenti austriaci, locali e italiani, Barth individua un itinerario di formazione intellettuale e propone un background culturale dal quale le nuove generazioni di architetti sudtirolesi non potranno più prescindere, se vorranno collocarsi sul versante avanzato della produzione architettonica e dell’impegno culturale».
Da queste parole emerge chiaramente la consapevolezza del fondamentale ruolo che Othmar Barth ha avuto nel sollecitare il territorio sudtirolese stimolando sia i progettisti che i committenti, e più in generale la società civile nel confronto con il contemporaneo, sfidando la sicurezza dell’ancoraggio alle tradizioni costruttive ereditate dal passato. Ecco quindi comparire nuove forme, essenziali e non retoriche, che derivano da una profonda conoscenza del contesto fisico e culturale, ma allo stesso tempo espressione della sintesi di una formazione capace di unire l’esperienza dei maestri della tradizione architettonica tedesca come anche di quella italiana, attraverso riferimenti colti all’architettura moderna.
Tra le prime opere di Barth, l’accademia Cusanus, sorta nel cuore del centro storico di Bressanone, esprime la capacità di condensare in uno spazio tensioni e relazioni definite dalle forme della struttura ma anche dalle forme della luce, in una lungimirante visione della committenza, un istituto religioso che si è affidato all’architettura per rappresentare concetti legati alla fede. Sempre a Bressanone, nella zona industriale, va in scena anche la celebrazione della capacità d’impresa dei privati: l’azienda Durst affida a Barth la realizzazione dei suoi nuovi stabilimenti, che si dovevano completare anche con un importante oggetto architettonico costituito da una torre, studiato approfonditamente e declinato in numerose possibili soluzioni, senza però giungere mai a costruzione. Uscendo dal centro abitato cittadino, sui pendii di Perara, in posizione rialzata rispetto al fondovalle, un convento con annessa una scuola femminile si insedia con una struttura fortemente autonoma, ispirata al convento della Tourette di Le Corbusier, introducendo un evocativo volume caratterizzato da corti interne e da una finitura in cemento a vista. Spostandosi invece più a sud, sulle rive del lago di Caldaro, l’impatto del nuovo albergo Ambach si misura con la conformazione morfologica del sito costruendo un particolare rapporto visuale con il lago e con il paesaggio dei vigneti. Infine a Egna una struttura modulare, ispirata a un’opera di Aldo van Eyck, riesce a comporre le funzioni e i volumi per ospitare un centro civico ed un asilo.
Questi approcci sono tra loro molto diversi, coerentemente adeguati al luogo in cui si insediano e alle funzioni che vengono ospitate. Non si tratta di eclettismo stilistico ma bensì di un intelligente e adeguato modo di rapportarsi con specifici temi progettuali e specifici luoghi fisici.
Riscoprendo nuovamente queste opere abbiamo potuto imparare «da Barth» una lezione di architettura ancora attuale e fertile. In questo numero proviamo a entrare ancora più nel profondo di tali lavori, verificando come essi reagiscono agli interventi di conservazione o trasformazione che abbiamo provato a raccontare in un doppio sforzo di indagine e di confronto tra gli elementi originari e le necessarie modifiche introdotte. Per fare questo abbiamo incontrato i progettisti che necessariamente si sono confrontati non solo con gli edifici ma anche con il linguaggio e la logica costruttiva di Barth. Inoltre abbiamo visitato, ove possibile, le opere cercando di compiere insieme ai «nuovi» autori un percorso che ci ha permesso di comprendere come è stato possibile lavorare con gli elementi ed i materiali di tali architetture potendo quindi imparare non solo «da» ma «con» Barth.
Per questo motivo abbiamo inizialmente chiesto a ciascuno qual è stato il loro rapporto personale con Othmar Barth, come architetto, docente, amico di famiglia o collega con cui confrontarsi, ma anche con la sua opera: ammirata come particolare architettura, passandoci accanto occasionalmente o vivendone gli spazi per brevi periodi. Si tratta di contatti particolari e personali, che anche ognuno di noi può avere avuto. Sensazioni ed esperienze che possono aver condizionato i nostri colleghi nel rapporto con le opere di Barth e nell’individuazione delle modalità di intervento più idonee per rispondere alle nuove esigenze funzionali. La responsabilità, ovviamente, non è solo nelle mani dell’architetto. Le richieste dei committenti condizionano pesantemente i progetti e ne determinano in parte la buona riuscita. Allo stesso tempo anche le condizioni fisiche e strutturali degli immobili, alcuni ancora in uso e altri in abbandono, influiscono sulla capacità di preservare il bene.
È infatti esemplare il caso dell’Accademia Cusanus, struttura ben utilizzata e preservata, unica opera di Barth vincolata da parte della Soprintendenza dei beni Storico artistici dell’AA, vista la consapevolezza del suo chiaro valore architettonico e culturale. L’intervento si manifesta in un vero e proprio restauro attento e delicato, che rimuove alcune superfetazioni aggiunte nel tempo, libera alcuni spazi per una loro migliore fruizione, e interviene con l’aggiunta di nuovi spazi solo nel piano interrato quindi poco visibili.
Lo stesso approccio lo si ritrova nell’Hotel Ambach, dove nonostante l’assenza di un grado di tutela, il tema della conservazione è rimasto lo stesso seguendo lo spirito del «Denkmalschutz ohne Denkmalpfleger», ovvero della tutela senza tutelatore. In questo caso va riconosciuto ai proprietari l’aver saputo cogliere il valore dell’edificio affidandosi sempre a Barth per le eventuali modifiche da introdurre nel corso del tempo. Dopo la scomparsa del Maestro, il testimone è passato a Walter Angonese, che subentra nel ruolo di consulente per le nuove modifiche, attuando un approccio ancora più attento di quello dello stesso Barth, che lavorando su un proprio progetto si poteva permettere una maggiore libertà di azione.
Diversa è invece la storia di Pairdorf, dove un’azienda si assume l’onere di rifunzionalizzare una struttura precedentemente utilizzata come convento e scuola, per anni in stato di abbandono, al fine di sfruttarne gli spazi come sede aziendale. Ciò ha comportato alcuni interventi di demolizione di importanti porzioni di edificio, ritenute non idonee o difficilmente riconfigurabili per le nuove esigenze. Ma forse la sfida più difficile è quella dell’efficientamento energetico della struttura, attraverso la posa di un pacchetto isolante esterno e la sostituzione dei serramenti originari. Si tratta di un tema di grande attualità ma che comporta interventi invasivi e trasformazioni radicali che modificano le superfici e la composizione dei prospetti.
Più violento, invece, è l’intervento presso la Durst, dove un nuovo edificio nasconde, o protegge, a seconda dei punti di vista, l’elemento continuo e orizzontale del volume principale del complesso aziendale. Il tema della torre mai costruita è qui ripreso e declinato in una versione energica e simbolica, capace di dare una nuova immagine alla ditta. L’edificio di Barth in qualche modo scompare, anche se si ritrova nel cortile posto al primo piano dove rimane la presenza dei brise-soleil al secondo piano.
Una storia ancora differente è invece quella del padiglione del turismo, che si inserisce in una serie di continue sostituzioni di una struttura temporanea che nel corso della più recente storia della città si riconfigura continuamente. L’opera di Barth, sorta anch’essa con un carattere temporaneo, subisce la stessa sorte dei padiglioni precedenti, ovvero la demolizione. Anche se in questo caso la struttura è smontata da un imprenditore locale che si propone di rimontarla in un altro luogo. Sarà interessante capire se il nuovo padiglione dello studio Modus avrà la capacità di interrompere questa successione di «omicidi» o se il futuro gli riserverà la stessa sorte.
Infine, la narrazione rimane ancora aperta per l’ampliamento dell’asilo annesso all’Haus Unterland di Egna. Presentiamo qui il progetto vincitore e i progetti segnalati, del concorso recentemente svolto, che documentano una fertile varietà di reazioni all’opera di Barth.
I lavori che abbiamo indagato presentano interventi diversi, dal restauro alla demolizione, realizzati con atteggiamenti tra loro differenti, contenendo in questi opposti una serie di sfumature che permettono di rispondere ad esigenze, contesti e situazioni molto diversificate. Approcci che esprimono la sensibilità di architetti e committenti di fronte ad un’architettura che, indipendentemente dal valore storico e artistico, dal grado di tutela, dall’epoca di costruzione, offre elementi di riflessione e di stimolo per alimentare nuove progettualità.
Aver potuto riscoprire insieme l’opera di Barth, indagarla, discuterla, analizzarla con i progettisti che hanno toccato con mano tali lavori, è stata anche per noi una lezione di architettura che ci ha permesso di attingere nuovamente da un inesauribile patrimonio.
Grazie Othmar
Alberto Winterle _Editoriale TURRIS BABEL 121_ 04|2021